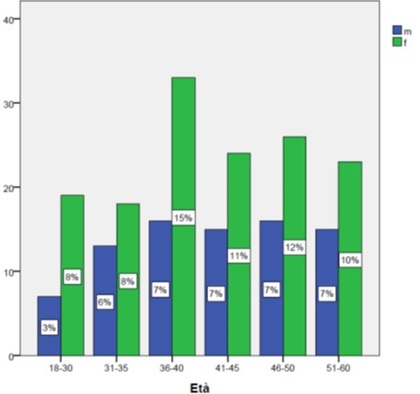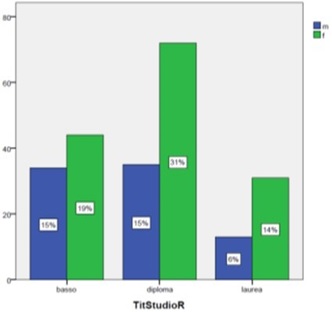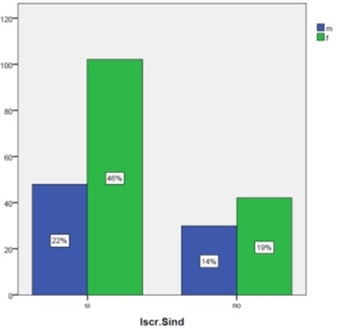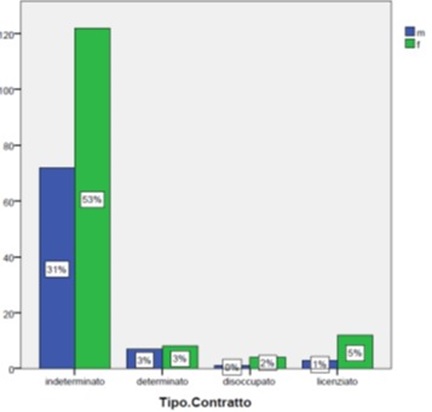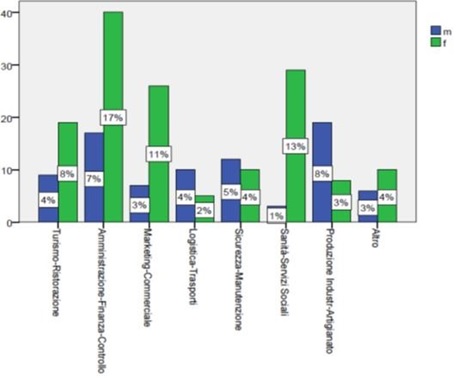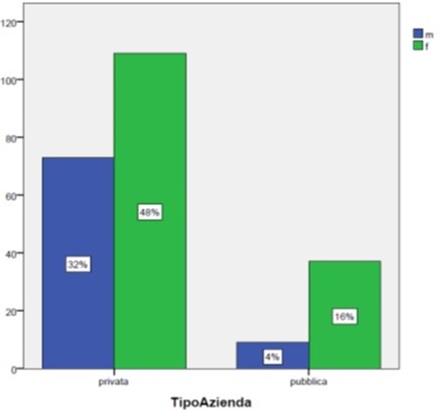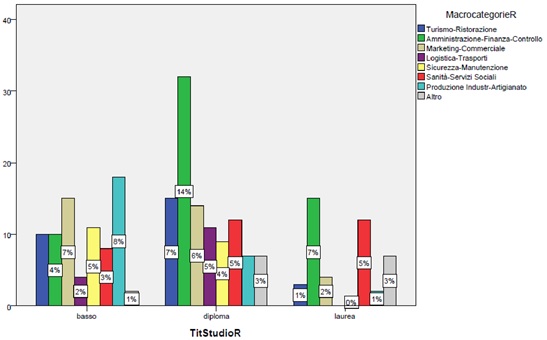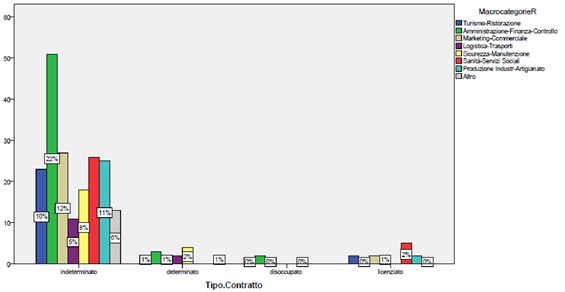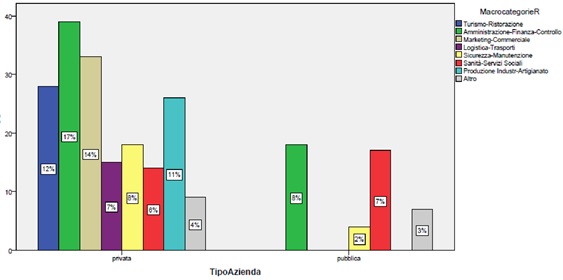“Io è un Altro”: cosa si cela dietro il mobbing?
Attraverso le indagini condotte per la realizzazione di questo studio è emerso sin da subito che all’interno di qualsiasi ambiente lavorativo è presente una silente realtà sociale, caratterizzata perlopiù da persone esiliate, emarginate, per usare un termine forte, da persone “messe da parte”.
Queste sono le persone vittime del fenomeno di mobbing, ampliamente descritto nel capitolo precedente, ma è oltremodo riduttivo e in parte scorretto attribuire questa etichetta – vittime del mobbing -, a coloro che quotidianamente sperimentano sofferenza sul luogo di lavoro.
I processi che portano a definire come mobbing una situazione di disagio lavorativo sono lunghi e caratterizzati da atti facilmente e largamente definibili; infatti, in letteratura sono molteplici gli autori presenti che determinano cos’è il mobbing, le sue cause e conseguenze e come può essere affrontato.
La funzione di ogni definizione è quella di apporre un “invisibile velo coprente” sopra ogni processo o fenomeno preso in considerazione, con il fine ultimo di delimitarne i confini, rendendone agevole la fruizione, soprattutto per coloro che decidono che dare un nome alle cose risolva in parte il problema.
Questo è quanto accade con il mobbing, termine confuso e “mal digerito” da ogni attore sociale che ne subisce direttamente o indirettamente gli effetti, sintomo del fatto che questo processo sociale non può essere incatenato asemplici parole descrittive. Il mobbing è solo un punto di partenza, un termine cui ancorarsi qualora la persona subisca atti vessatori sul posto di lavoro, ma non esplica apertamente quanto realmente accade alla persona che ne soffre.
Il concetto di malessere lavorativo lega assieme una gamma di fenomeni quali lo stress, il mobbing, il burnout e lo straining, che decretano ancora una volta la necessità da parte degli “addetti ai lavori” di circoscrivere un mondo che in realtà solo in parte è veramente conosciuto.
I costrutti teorici appena citati decretano lo status di vittima appartenente a quella categoria di persone che quotidianamente subiscono violenze psicofisiche sul luogo di lavoro. Per certi aspetti è facile dire chi è la vittima, la letteratura internazionale e nazionale con l’ausilio di studi ventennali effettuati sul campo sancisce la presenza di una gamma sconfortante di fasi che stabiliscono come e perché il perseguitato è divenuto tale.
Effettuando le dovute ricerche tipiche di chi affronta uno studio come quello presentato in questa sede, si percepisce sin da subito che il mobbizzato e il mobber, vittima e carnefice, trovano il loro posto su pagine che tengono a precisare cosa si può fare o non fare per prevenire e combattere il mobbing, che possiede le caratteristiche intrinseche di una malattia .
Il mobbizzato è quindi “portatore sano” di una determinata malattia?
Così sembra, o almeno, è ciò che si vuol trasmettere agli addetti ai lavori e ai neofiti della materia: il “malato mobbizzato” è un essere svilito, impaurito, incolpevole, esasperato e privato dell’autostima e della dignità dovuta ad ogni lavoratore.
A questo punto, definire il lavoratore mobbizzato come stressato, affetto da sindrome da burnout, strainizzato e stalkizzato, è quanto di più spaventoso si possa fare; d’altronde, se nelle competenti sedi giuridiche non si è etichettati e giudicati affetti da “qualcosa”, non si viene neanche presi in considerazione.
Nulla si vuol togliere al fatto che lo sviluppo di tale fenomeno sociale cui derivano conseguenze dannose, comporti la necessità di tutelare i lavoratori divenuti vittime, per farlo è necessaria l’attribuzione di una causa e di un effetto che relega l’atto vessatorio al concetto di reato.
Le leggi citate nel paragrafo 1.5 dedicato all’aspetto giuridico del fenomeno sono ripieghi effettivamente utili che sanciscono la possibilità di proteggere le persone danneggiate, “macchine umane” che il più delle volte vengono prese in considerazione solo perché “fanno troppo rumore”, non tanto per il fatto che stanno male e basta. Psicologi e avvocati arrivano al punto in cui è paradossalmente necessario accantonare le leziosità umane per dare spazio a concezioni più concrete, determinanti per donare alla vittima un senso di sollievo; il conforto si traduce a volte in risarcimenti economici per quanto subito a causa di danni pervenuti dai propri colleghi e dai propri superiori. Il vessato è tale se un tribunale dice che può esserlo: questo può risultare utile, soprattutto se la persona risulta vincente, se la persona risulta “giuridicamente”malata.
Gli ingranaggi appena descritti fanno parte di una meccanismo complesso, in cui la vittima è lasciata momentaneamente da parte affinché possa essere curata per vincere burocraticamente quella malattia di cui è affetta, malattia che, va ora ricordato, è in realtà espressione psicofisica di un disagio.
Nel libro Il lavoro perverso (Blasi, 2005, p.73), è scritto:
“Le torture ci divertono. Senza sangue e volgarità eccessive chiunque è interessato alle dinamiche del potere, e all’umiliazione delle vittime.
Fa sempre piacere vedere come va a finire un confronto violento”.
Questa affermazione agghiacciante ma quanto mai veritiera, attribuisce all’animo umano una “connotazione naturalmente perversa”, stabilendo che è insita in ogni essere umano la curiosità per tutto ciò che sarebbe buona norma non sentire.
Un confronto violento: sono queste poche parole che meglio descrivono l’attuarsi di forme vessatorie nei confronti di un lavoratore.
Non c’è legge o costrutto psicologico che vadano a disturbare in profondità il modo di sentire della persona, ci si ferma sempre allo scalino precedente, postazione da cui è più facile osservare.
Il disagio nelle relazioni lavorative è, come sostiene Leymann (1996), terrore psicologico, perché della dignità dell’essere umano rimane ben poco, il carnefice vuole il sangue della sua preda, che spesso lavora nella scrivania di fianco alla sua o nell’ufficio accanto.
Umiliare la vittima è sintomo di una patologia che appartiene al persecutore che a sua volta è causa della patologia del perseguitato. I tabù della società odierna celano quanto di più primitivo appartiene all’essere umano, cercando in tutti i modi di sedare il gusto per le forme più o meno velate di violenza, dicendo all’essere umano cosa può o non può sentire, provare, esperire attraverso le proprie emozioni (Zamperini, 2001).
Per questo Blasi ci tiene a precisare che la presenza di sangue e di volgarità non deve essere eccessiva, perché il “troppo” acuirebbe la percezione di uno scandalo che si sta compiendo, ad esempio, in una sede lavorativa.
Non è ciò che vogliono le persone che stanno a guardare, gli spettatori ne risulterebbero troppo coinvolti, per questo a volte è meglio censurare, zittire, porre una mano sulla bocca di chi grida e che pertanto non può essere ascoltato.
Lo spettatore è accontentato, è cosciente della sofferenza che a pochi passi da lui sta avvenendo, ma non ne sente l’effettivo peso, perché chi vessa è bravo a celare, a nascondere la violenza.
Colui che non accetta di essere zittito trasgredisce alla buona norma sociale da tutti accolta, il vessato che alza la testa in segno di protesta è un caso isolato che riporta sotto la luce dei riflettori quell’oscenità di cui non si vuol sentir parlare.
“…la trasgressione immette cambiamento, una sovversione del canone convenzionale. Contro l’egemonia del sentire comune che invita a stare al proprio posto. Praticando una sorta di diserzione emotiva nei confronti del governo dei sentimenti. Revocandogli la delega. In un tale scenario, i veri buoni samaritani sono dei dissidenti emotivi. Artefici di un’insubordinazione emozionale ossia di una discrasia tra ciò che sentono in una determinata situazione e ciò che invece dovrebbero provare secondo quanto prescritto dalle nome collettive. E perciò affrancati da sentimenti di seconda mano.”
Le parole utilizzate da Zamperini (2007, p.165) sovvertono la buona norma, ridonano al dissidente il posto che gli spetta: la perversione non è più “perversione”, la ferita inferta dal collega violentatore torna a sanguinare senza in realtà aver mai smesso, il gioco dei potenti torna ad essere il gioco dei malvagi.
La buona norma che si aggrappa al senso comune perde d’efficacia e cade la maschera di coloro che professano un buonismo inesistente, sorretto unicamente da una collettività che vuole stare comoda.
I sentimenti riciclati cui si fa riferimento nella citazione sono egregiamente posseduti e maneggiati dai vessatori quanto dagli spettatori, che accettano quotidianamente il fato silenzioso cui, a quanto pare, non si può porre rimedio.
Ege (2001) esplicita in larga misura quali sono gli effetti dannosi che il disagio nelle relazioni interpersonali lavorative ha sul lavoratore vessato, affermando che il mobbing ha conseguenze devastanti sulla persona colpita: essa viene danneggiata psicologicamente e fisicamente, menomata della sua capacità lavorativa e della fiducia in se stessa. I soggetti mobbizzati mostrano alterazioni dell’equilibrio socio-emotivo, alterazioni dell’equilibrio psicofisiologico e disturbi a livello comportamentale.
In sostanza le vittime del mobbing vanno incontro ad una crisi che è innanzitutto esistenziale, nel senso che la perdita del ruolo di lavoratore, epilogo che si presenta frequentemente, mina le fondamenta dell’identità personale e la propria autostima. Il fatto che la collettività accetti comportamenti di questo tipo aumenta la possibilità che la violenza venga vista come “normale”, come vissuto quotidiano.
L’inconsapevolezza con cui questo sadismo viene messo in pratica è un’indicazione del fatto che ormai le violenze in azienda vengono vissute senza troppo disagio da parte di chi commette l’atto e di chi assiste.
Essere inconsapevoli è pratico, comodo, permette di non gettare troppo in là lo sguardo verso lo stato di chi soffre.
Opposta alla figura del buon samaritano che dissente, Zamperini (2007, p.8), pone la figura del passante, dello spettatore, attore inconsapevole cui fa riferimento Blasi, un essere “tutto preso da se stesso e sempre di fretta”.
Nella società incerta in cui a gomitate tentiamo di prendere posto, non interpretiamo mai lo stesso ruolo: a volte siamo noi stessi carnefici, ma l’istante dopo, in un contesto diverso, possiamo essere vittime (Favretto, 2005).
Impugnare o essere sottomessi all’arma che mira a distruggere la dignità dell’uomo non è solo una questione di prospettive; ne conviene che questo scambio di ruoli deleterio porta solamente all’attuazione di pratiche che spesso non comprendiamo pienamente, anche quando siamo in procinto di scagliare il colpo o pronti a riceverlo.
Attorno all’azione violenta vi è sempre un pubblico che attende: l’epilogo è incerto come lo sono gli attori che si avvicendano sul palco, quel che è certo è che il pubblico vuole vedere come andrà a finire.
Lo spettacolo aberrante che avviene quotidianamente negli ambienti lavorativi è già di per sé sufficiente a determinare che una società intera – l’ufficio delle poste, l’azienda aeroportuale, il mercato ortofrutticolo vicino casa, la casa di cura – è coinvolta attivamente nel momento in cui atti violenti vengono perpetrati al suo interno. Coinvolgimento, appunto. Ma tutto tace, la vittima soffre, la vittima cede, muore: l’aggressore non è stato – volutamente – riconosciuto come colpevole, ma neanche coloro che sono stati a guardare.
“L’aggressore può così sviluppare ed esibire un manierismo d’innocenza, che lo solleva in alto a spese altrui, con lacoscienza libera da qualsiasi conflitto, scaricando con maestria sulla vittima il peso di una situazione a volte mortale” .
Con queste parole Blasi (2005, p.73) afferma che l’aggressore viene messo sul piedistallo dell’innocenza, senza conseguenza alcuna, a discapito della vittima che può giungere a conseguenze estreme.
Ed è proprio la figura dello spettatore che permette tutto questo: seppur apparentemente incolpevole, lo spettatore, lasciando modo al carnefice di attuare le proprie strategie vessatorie, si rende suo complice.
“Tutto preso da se stesso e sempre di fretta” (Zamperini, 2007, p.8), il collega della vittima vessata sembra non rendersi conto di quanto sta accadendo: ma anche se così non fosse, perché mai mettersi contro il carnefice, con il rischio di diventare a sua volta una vittima?
Non avrebbe alcun senso.
A meno che quel semplice passante non diventi un dissidente (Zamperini, 2007, p. 65), certamente rischiando – il posto, la carriera, una sicurezza economica -, buttando giù dal piedistallo quell’aggressore che fino a quel momento l’ha passata liscia.
Un combattente inconsueto, raro ma necessario: come specificato da Azzarini, la testimonianza da parte di terzi risulta assolutamente necessaria affinché il lavoratore vessato trovi consolazione economica come risarcimento di un periodo passato a subire.
Aldilà dell’aspetto economico, per la persona emarginata e ostracizzata sul luogo di lavoro può risultare di conforto sapere che persone vicine possano supportare le difficoltà emergenti.
Le avversità che il perseguitato affronta nel quotidiano si ripercuotono in tutti gli aspetti della vita: oltre all’ambiente lavorativo, anche quello famigliare risente dello stato d’animo del lavoratore vessato.
Ege (1997), denomina questo fenomeno doppio mobbing, una tipo di mobbing che lo psicologo tedesco ha avuto modo di riscontrare soprattutto in Italia: è infatti legato al ruolo particolare che la famiglia ricopre nella società italiana.
La famiglia si fa contenitore dei problemi del vessato, condividendone le conseguenze e le ripercussioni, diventando essa stessa vittima di mobbing.
L’ausilio della famiglia non può che giovare alla persona che sente il peso del fallimento sulle sue spalle, paradossalmente il lavoratore torna a casa vergognandosi della propria situazione, poiché non riesce a venirne a capo, sapendo che il proprio malessere influirà negativamente sui rapporti famigliari.
Tamponare la falla (Ege, 1997, p.7) è massacrante per tutte le parti coinvolte, anche perché il contenitore famigliare, riprendendo la metafora di Ege, può ad un certo punto non sopportare più quanto in esso viene travasato.
La goccia che fa traboccare il vaso mostra l’altra faccia della medaglia, la famiglia non è più un appiglio ma una concausa del mobbing, non è più un rifugio ma qualcosa da cui si tenderà a fuggire.
Il mobbing è raddoppiato: come se non fosse sufficiente, quando i processi del mobbing raggiungono il loro apice, decade il sostegno su cui precedentemente il lavoratore poteva contare. La famiglia diventa il nemico inconsapevolmente complice dell’azienda perché a sua volta si sente vittima. Pertanto i componenti del nucleo famigliare col tempo tenderanno a tirarsi indietro, a non sostenere più la vera vittima.
Verrebbe da dire “e come se non bastasse”: al peso gravoso che il lavoratore è costretto a sopportare ogni giorno, si aggiunge quello della famiglia che tende a ritrattare il proprio bene più che altro per tutelarsi, per non essere a sua volta tirataverso il basso.
Ne derivano le opzioni del caso, le separazioni coniugali e tutto ciò che ne consegue. Il carnefice è andato oltre, ovviamente senza rendersene veramente conto: il perpetrarsi di azioni vessatorie ha trasformato la vittima preferita sul luogo di lavoro in una vittima totale.
Ancora una volta è quindi il lavoratore a rimetterci, ma questa volta il carnefice non è solo il mobber: i coprotagonisti di questa dramma diventano la famiglia, gli amici, la società nel senso più ampio.
L’individuo colpevole, l’individuo vittima: apparentemente nessuna differenza, la percezione distorta che l’uomo ha dell’uomo porta a non riconoscere più i confini di quella moralità che, seppur per certi versi statica, risulta comunque necessaria (Zamperini, 2010).
L’egoismo è indifferenza, l’indifferenza travolge silenziosamente la vittima soffrente, la vittima che muore.
Nel romanzo Il responsabile delle risorse umane di Yehoshua Abraham, questa stretta connessione fra indifferenza e morte nell’ambito lavorativo, viene resa esplicita dalla figura di una donna straniera che viveva da sola in una squallida baracca di un quartiere di religiosi, che muore a causa di un’esplosione provocata da un terrorista suicida che si fa esplodere in un mercato di Gerusalemme.
Nessuno va a reclamare il suo cadavere all’obitorio. Eppure la donna aveva ancora formalmente un lavoro, come addetta alle pulizie in un gran panificio della città. Un giornalista senza scrupoli sfrutta il caso per imbastire uno scandalo e denuncia la mancanza di umanità dell’azienda che non si è nemmeno accorta dell’assenza della dipendente.
Tocca al responsabile delle risorse umane, spedito in missione dall’anziano proprietario del panificio, cercare di rimediare al danno di immagine.
La denuncia sociale che questo libro tenta di esporre fa leva su un caso estremo di indifferenza; la realtà scomoda di cui nessuno si accorge, diventa viceversa allarmante per un giornalista che tenta di capire come certe cose possano accadere (Zamperini, 2007).
Dimenticarsi di una vita, di una donna: il responsabile delle risorse umane, dapprima totalmente all’oscuro di quanto accaduto, diviene con il proseguo della storia il responsabile della salma della vittima, di una “risorsa umana” di cui ignorava l’esistenza.
Il coinvolgimento inizialmente infimo diventa totale: la donna ha un nome, un volto, un figlio e una famiglia d’origine, cose che tutti ignoravano.
Seppur per ragioni d’immagine, che spingono l’azienda in cui lavorava la donna a farsi carico delle spese inerenti il funerale, la vittima assume finalmente un’identità. Ormai è tardi, la donna è morta, il responsabile delle risorse umane non ricorda neanche di averla assunta: attraverso il viaggio che condurrà la salma a casa dei famigliari, il protagonista del romanzo entrerà in contatto con la realtà della donna, la sentirà per la prima volta “viva” nella sua morte.
La vicenda proposta da Yehoshua Abraham sembra lontana anni luce da quello che quotidianamente viene percepito attraverso il sentire comune, ma gli avvenimenti attuali ci parlano di una realtà non tanto lontana da quella che Il responsabile delle risorse umane ci propone: l’uomo è incatenato al suo preannunciato fallimento lavorativo, l’ostracismo violento e l’ennesimo appiglio mancato portano a conseguenze estreme che sono preludio di una fine quasi mai incerta ma comunque catastrofica. È questa la società dove tutto scivola via velocemente, dove il corpo svuotato
(Zamperini, 2007, p.18) cade vittima dell’indifferenza di cui solo a posteriori ne si capiscono le vere conseguenze.
Sennett (2001, p.119), chiarisce come le dinamiche vessatorie che avvengono nella sede lavorativa siano il preambolo per il fallimento prossimo della vittima:
“Il fallimento è uno dei grandi tabù moderni.
La manualistica popolare è piena di ricette per il successo, ma non dice molto su come affrontare un fallimento. Riuscire a fare i conti con un fallimento, dandogli una forma e un posto nella storia della propria vita, è una cosa che può ossessionarci interiormente ma che di rado viene discussa con gli altri.
Al contrario, spesso ci affidiamo alla sicurezza dei cliché: i difensori degli sventurati si comportano in questo modo quando cercano di trasformare un lamento tipo ‘ho fallito’ con una risposta che dovrebbe essere consolatoria, tipo ‘no, tu sei solo una vittima’.
E, come succede sempre con le cose di cui abbiamo paura di parlare apertamente, l’ossessione interiore e la vergogna non fanno che crescere. Quella che rimane sempre attiva è la cruda idea di non essere
‘all’altezza’”.
La visione di un nuovo capitalismo proposta da Sennett (2001), fotografa sostanzialmente l’ambiente in cui l’uomo è lasciato a se stesso: l’autore osserva come i cambiamenti radicali che hanno trasformato questa società non hanno fatto altro che impoverire la gente con la presunta intenzione nobile di arricchirla.
La persona dimenticata arranca, non riesce a stare dietro a questo continuo cambiamento che decreta il non ritorno ad una vita certamente più lenta ma fatta di relazioni vere, in cui i punti di riferimento erano stabili e concreti.
All’uomo flessibile di Sennett è richiesto di sapersi adattare a questo nuovo mondo che plasma figure incerte il cui scopo a volte sfugge: sorgono relazioni precarie, persone che a malapena si sfiorano e nonostante questo vengono quotidianamente assorbite da responsabilità che in realtà non gli appartengono, persone che spesso non hanno neanche un volto, come la protagonista del romanzo di Yehoshua Abraham.
La persona costretta ad affrontare battaglie giornaliere che mano a mano la consumano erodendola dall’interno, si troverà costretta a prendere una decisione affinché la situazione di disagio cessi al più presto.
Persone esautorate e depauperate della propria dignità non riescono più a trovare un motivo per andare avanti, persone spesso sole che non hanno qualcuno cui chiedere sostegno.
Favretto (2005) colpisce nel segno quando sostiene che quando ci viene a mancare il sostegno delle persone per noi significative, ci sentiamo immediatamente tristi e melanconici, tutto perde di significato e veniamo assorbiti dall’idea che ora siamo soli e siamo stati abbandonati; a ciò può conseguire uno stato depressivo e, nei casi estremi, l’autoeliminazione fisica.
Il vuoto che si crea attorno alla persona è incolore e insapore, nessuno vede, tutti tacciono. Il lavoratore vessato non reagisce, è spento, sta guardando in basso in attesa di una decisione da prendere.
Una volta tolto il “velo coprente” sotto cui si nasconde tutto ciò che chiamiamo doverosamente mobbing, scopriamo la realtà: uomini lavoratori che hanno paura di raccontarsi, donne lavoratrici in attesa di un figlio e che per questo vengono accusate di non tenere abbastanza al loro lavoro, ragazzi stranieri che, in quanto tali, vengono continuamente sfruttati.
Gente “qualunque” che domani andrà a lavorare trascinandosi dietro un macigno enorme, che durante le ore lavorative non perderà occasione d’essere insultata o emarginata, che la sera tornerà a casa in lacrime, da una famiglia sfasciata a causa di quell’ambiente lavorativo logorante.
Sennett (2001, p.148), conclude il suo pensiero dicendo:
“Se il cambiamento deve verificarsi, si verifica sul terreno tra gente che parla con franchezza dei propri bisogni interiori più che attraverso sollevazioni di massa. Ma un regime che non fornisce agli esseri umani ragioni profonde per interessarsi gli uni degli altri non può mantenere per molto tempo la propria legittimità.”
L’interesse reciproco sembra essere “la soluzione”: chi è costretto ad affrontare un disagio nelle relazioni lavorative non deve essere per forza solo.
Lo psicologo De Felice e l’avvocato Azzarini dello sportello antimobbing della CGIL di Venezia Mestre, rappresentano per molti un’inversione di rotta senza la quale si finirebbe alla deriva, dove il cosiddetto mobbizzato perderebbe completamente interesse nei confronti della vita.
“Io è un Altro”, così scriveva un giovanissimo A. Rimbaud nella celebre opera Una stagione all’Inferno: l’uomo tenderà sempre ad evolversi, costringendosi a divenire sempre più flessibile, a sostenere sul volto quella maschera che – oggi allegra, domani sofferente – meno debilita il collega, il datore di lavoro, la propria famiglia.
Ma l’Altro è lì vicino, ne annusiamo la sofferenza, ne percepiamo il dolore che lo attanaglia, in fondo è “solo” nell’ufficio accanto al nostro: il disagio che lo strozza può essere placato, l’indifferenza può essere abbattuta, l’essere umano può riconquistare la dignità che gli spetta di diritto.
Lo spettatore deve abbandonare quel posto comodo gelosamente custodito e entrare a far parte della recita, diventando complice di quel disagio, accettando le conseguenze di chi decide per una volta di stare dalla parte “sbagliata”.
“Il lavoro che (non) fa per te”. Il disagio nelle relazioni lavorative: un’indagine psicosociale sul territorio di Venezia – © Maurizio Casanova